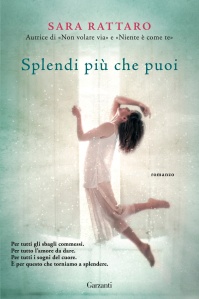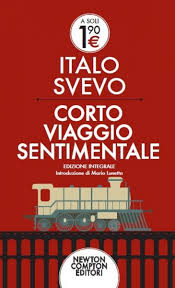PREMESSA
Ho iniziato a leggere il nuovo romanzo di Alessandro D’Avenia con un po’ di apprensione dopo aver letto questo post dell’amico blogger frz40 che inizia con queste parole: «Se avete presente “Bianca come il latte, rossa come il sangue” o anche solo “Cose che nessuno sa“, beh, scordateveli: qui è tutta un’altra musica.»
Frz, riportando l’incipit del libro, faceva notare la scrittura barocca, arzigogolata, lontana da quella dei due romanzi precedenti.
Nel commentare questo post, dopo la lettura delle prime 100 pagine – letteralmente divorate – osservavo:
«In effetti concordo sulla scrittura un po’ troppo ampollosa, ricca di retorica, talvolta decisamente inutile perché ridondante. Ma poi tutto cambia perché è inevitabile, a parer mio, essere catturati dalla storia, bellissima nella sua crudezza.»
Ora posso dire che Ciò che inferno non è mi è piaciuto molto e ne consiglio davvero la lettura non solo a tutti quelli che amano lo stile del prof-scrittore ma anche a chi non lo conosce e non ha letto i suoi precedenti romanzi. [QUI il mio contributo su Bianca come il latte, rossa come il sangue]
L’AUTORE
 Alessandro D’Avenia nasce a Palermo il 2 maggio 1977. Dal 1990 frequenta il liceo classico Vittorio Emanuele II. Qui incontra padre Pino Puglisi, suo insegnante di Religione, che gli ha ispirato la stesura del suo terzo romanzo, Ciò che inferno non è (Mondadori) edito ad ottobre 2014.
Alessandro D’Avenia nasce a Palermo il 2 maggio 1977. Dal 1990 frequenta il liceo classico Vittorio Emanuele II. Qui incontra padre Pino Puglisi, suo insegnante di Religione, che gli ha ispirato la stesura del suo terzo romanzo, Ciò che inferno non è (Mondadori) edito ad ottobre 2014.
Terminato il liceo, frequenta la facoltà di Lettere classiche all’Università La Sapienza di Roma, dove si laurea nel 2000. Nel 2004 consegue il dottorato di ricerca in letteratura greca con specializzazione in Antropologia del mondo antico, terminandolo con una tesi sulle “sirene” in Omero e il loro rapporto con le Muse nel mondo antico. Nel frattempo insegna per tre anni nelle scuole medie e, terminato il dottorato, frequenta la scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario, che gli consente di proseguire la carriera di docente di greco e latino al liceo.
Nel 2010 pubblica il romanzo d’esordio Bianca come il latte, rossa come il sangue che presto diventa un successo internazionale, raggiungendo il milione di copie e diciannove traduzioni nel 2013. L’anno successivo vede la luce il secondo romanzo, Cose che nessuno sa, che rapidamente scala le classifiche di vendita.
Ciò che inferno non è, come già detto, è la terza fatica di D’Avenia.

LA TRAMA
Ciò che inferno non è è un’opera narrativa e come tale frutto di fantasia. Tuttavia D’Avenia non ha mai fatto mistero di quanto sia stata importante nella sua crescita e formazione la presenza di Padre Pino Puglisi – detto affettuosamente 3P -, il prete assassinato dalla mafia il 15 settembre 1993, giorno del suo 56esimo compleanno. Il romanzo, ripercorrendo gli ultimi mesi di vita di Puglisi, allora parroco a Brancaccio, quartiere periferico di Palermo, trae spunto in parte dal fatto di cronaca – l’omicidio del sacerdote, appunto – e in parte è il frutto di una testimonianza diretta, quella del diciassettenne Federico, allievo di 3P, che non è difficile identificare con l’autore stesso.
Nel romanzo si intrecciano, dunque, cronaca, ricordi personali, fatti ispirati alla realtà, mescolati con elementi fittizi, a creare il tessuto narrativo del romanzo che possiamo definire autobiografico.
Le vicende narrate sono calate in uno scenario che vede protagonista la città di Palermo, con le sue viuzze di periferia e le ampie strade che percorrono il suo centro. Palermo – Tuttoporto (tale è, infatti, l’etimologia del nome, dal greco παν-όρμος (Panormos, “tutto-porto”) in quanto i due fiumi che la circondavano, il Kemonia e il Papireto, creavano un enorme approdo naturale) è una città in cui il mare ha un ruolo importante, con l’attività dei pescatori, le bancarelle, il vociare di venditori e clienti, con le sue spiagge, prima fra tutte Mondello, le cui sabbie ospitano democraticamente poveri e ricchi, gente onesta e criminali, vecchi e bambini. Perché Palermo è così, città dalle due facce e dai molti tentacoli, quelli del polpo che avvinghia, stritola e non lascia scampo. Città segnata da una ferita che ancora non è cicatrizzata, né lo sarà mai, procurata dalle recenti stragi di mafia perpetrate ai danni dei giudici Falcone e Borsellino.
C’è la Palermo bene, quella cui appartiene Federico, con la sua bella casa in centro, una famiglia benestante, le vacanze al mare, i viaggi studio all’estero, l’istruzione e la cultura che rende liberi. Un mondo dorato, almeno così sembra. Se non è paradiso ci assomiglia molto.
Poi c’è la Palermo di periferia, con i suoi palazzoni, la gente umile e ignorante che ritiene la cultura inutile, oltre che un lusso irraggiungibile. Uno dei luoghi dell’altra Palermo è Brancaccio, con le strade che nascondono agguati e il mare tanto lontano che nemmeno si vede. La gente che vi abita è senza scampo, almeno così crede. Bambini abituati a lottare con la violenza e la fame, a sfidare i pericoli e a dimostrare la forza in atti di crudeltà come prendere a calci e pugni animali indifesi. Destinati a cambiare, crescendo, le vittime prescelte, non più cani ma uomini. Tanto il sangue sempre quel colore ha.
Brancaccio, se inferno non è, ci assomiglia molto.
L’inferno ha una sua unità minima, uno stato molecolare identificabile: è l’interruzione del compimento, la compressione della vita, non la sua comprensione. Tutto ciò che la sporca, ferisce, chiude, interrompe, distrugge, e ogni possibile variazione sul tema dell’interruzione, è inferno. Per opporvisi occorre riparare, riannodare, restaurare, ricominciare, riconciliare…
Don Pino sa che l’inferno opera più efficacemente sulla carne tenera: i bambini. Bisogna difendere la loro anima prima che qualcuno gliela sfratti. Custodire ciò che hanno di più sacro. (pag. 114)
Quando i due mondi s’incontrano, sembra non esserci speranza per chi viola un territorio segnato. La Palermo bene deve rimanere al suo posto, a maggior ragione se vuole dimostrare di essere migliore. Così Federico, invitato a Brancaccio da Padre Puglisi, alla fine della scuola in quell’estate del 1993, deve fare i conti con la diffidenza, nella migliore delle circostanze, e con la violenza, nella peggiore.
Padre Pino chiede al ragazzo la sua collaborazione al centro da lui fondato, il Padre Nostro, in cui cerca di sottrarre i più piccoli al destino criminale cui sembrano votati fin dalla più tenera età. Federico si trova di fronte ad una realtà così diversa, immaginata forse, perché la mafia non è sconosciuta a chi vive nel capoluogo siciliano, ma mai sperimentata così da vicino. Si trova combattuto tra il mondo dorato in cui vive, fatto di libri e amore per la letteratura, Petrarca soprattutto, e la miseria che caratterizza l’esistenza delle famiglie che abitano a Brancaccio, molte delle quali cercano con tutte le forze di opporsi alla violenza e al sangue che scorre di continuo sulle sue strade.
Nella lotta contro la mafia, 3P spesso usa parole come “giustizia” e “felicità”. Parole apparentemente sterili ma che celano una forza insospettabile se spiegate attraverso le pagine del Vangelo.
La felicità sta nell’essere saziati, non certo nel morire di sete o di fame. La giustizia di cui si parla è la promessa che Dio ha fatto agli uomini, e cioè che la sua forza prevarrà, che l’amore avrà sempre l’ultima parola, anche quando la violenza sembra soffocarlo. E’ una giustizia strana: si fa largo nel mondo silenziosa, nascosta ma inarrestabile, come un latitante che non si fa prendere mai. Saremo saziati perché lui fa quello a cui noi non arriviamo. (pag. 183)
Nonostante il divieto imposto dalla sua famiglia di frequentare il quartiere malfamato e l’imminente viaggio in Inghilterra, premio per la meritata promozione, alla fine Federico rinuncia ai privilegi che la vita agiata gli offre, non parte per il Regno Unito e decide di dare il suo contributo al centro di don Pino. Viene catturato dall’innocenza e dalla voglia di scoprire nuove cose che anima i bambini di cui 3P si prende cura: Totò, Riccardo, Francesco, la bambina con la bambola da cui non si separa mai. Inizia a dare lezioni di chitarra e si fa coinvolgere nell’allestimento di uno spettacolo con cui i ragazzi del centro Padre Nostro hanno in mente di festeggiare il compleanno di don Pino, il 15 settembre. C’è tutta l’estate davanti e per Federico non sarà uguale alle altre.
Il giovane riesce a vincere l’ostilità della famiglia, preoccupata per la sua incolumità. Anche il fratello Manfredi, che all’inizio lo sfotte per l’idea balzana che gli è venuta in mente, rompe le riserve e si lascia coinvolgere. Per il giovane liceale, complice del cambio di rotta è Lucia: una ragazza che fin da subito attrae l’inesperto Federico, troppo calato in un mondo fatto di parole, quelle delle poesie che gli hanno fatto conoscere l’Amore – primo fra tutti quello di Petrarca per Laura -, per passare ai fatti.
Sono fermo da mezz’ora davanti alla libreria e cerco qualcosa per Lucia. Voglio prestarle uno dei miei libri, ma non so quale scegliere. Sarà il libro a scegliere lei. […] Sempre ad occhi chiusi sollevo il braccio destro e lo punto verso gli scaffali: l’indice si scontra con un dorso. Il mio Petrarca. Il Canzoniere, chi meglio di lui. Lo ficco nello zaino e mi avvio verso Brancaccio. Petrarca a Brancaccio non c’è mai andato, questo è certo. Almeno ho un primato nella storia della letteratura: ce l’ho portato io. (pag. 98)
Piano piano vincerà la timidezza e dichiarerà il suo amore a Lucia, pur sapendo di rischiare grosso perché i picciotti che abitano in quei luoghi mal sopportano chi, venendo da fuori, mette gli occhi sulle loro proprietà, donne comprese.
Per difendersi e difendere i più deboli, oppressi da rapporti di forza che non possono trovare un equilibrio, le parole ormai non bastano più. Ci vuole coraggio ma soprattutto Amore per cambiare le cose, o almeno tentare. In un microcosmo fatto di delinquenza e prostituzione, la violenza è lo strumento privilegiato di cui la mafia, con i suoi affiliati, si serve per dimostrare la propria superiorità. Solo due parole sembrano degne dell’evidenziatore sul vocabolario mafioso: dignità è onore costituiscono il binomio imperfetto, in contrapposizione a quello perfetto – coraggio e Amore – che anima don Pino e i suoi “figli”.
Nonostante tutto il coraggio e l’Amore che dimostra nella sua quotidiana lotta contro la violenza e la sopraffazione di persone innocenti, non basteranno a don Pino a salvarlo dai nemici che vedono in lui un ostacolo scomodo. Uno che trova nella forza delle parole, nella persuasione, ciò che altri cercano nella canna di un fucile o in un pugno sferrato nella notte.
Ci sono mani che entrano nell’anima per dilatarla, altre per schiacciarla. Le prime sono forti ma delicate. Le seconde sono mani dure e feroci. Sono le mani che minacciano ancora don Pino e gli spaccano la faccia in un altro agguato, nei locali della chiesa, a tarda sera. Le mani funzionano come le parole, servono a maledire e benedire, carezzare e colpire, cucire e strappare. La carne si rattrappisce per effetto del dolore e l’anima si ritrae in un cantuccio. Non quella di don Pino: si dilata anche nel dolore, perché è il dolore che un padre deve patire per nutrire e difendere i suoi figli e la sua sofferenza è l’origine della soluzione. (pag. 262)
Padre Puglisi sa che il suo destino è segnato. Non quello di molti altri a cui ha insegnato a distinguere, grazie all’Amore, l’inferno da ciò che inferno non è.
***
C’è molto di Alessandro in quest’ultimo romanzo, come nei precedenti del resto. Dalle pagine del libro traspare l’amore per i libri, la letteratura, le parole e i segni, l’arte e i paesaggi della sua terra. C’è, inoltre, quella caratteristica di romanzo di formazione presente anche in Bianca come il latte, rossa come il sangue e Cose che nessuno sa.
In Ciò che inferno non è, tuttavia, c’è molto di più perché attraverso gli occhi e la voce di Federico, l’autore può raccontare questa storia bellissima e crudele al tempo stesso, dalla posizione privilegiata di osservatore diretto. Per questo i piani narrativi sono due: quello che ripercorre la Storia, seppur con le licenze che si concedono alla fantasia dello scrittore, per cui D’Avenia utilizza la terza persona e quello che racconta l’esperienza personale del liceale diciassettenne, caratterizzato dal ricorso alla prima persona. Un espediente, questo, che valorizza la preziosità della testimonianza diretta.
Lo stile, come già notato nella premessa, è a volte troppo retorico, con l’uso di similitudini e metafore che spesso creano l’effetto contrario a quello voluto, probabilmente. Non si può non apprezzare il bello scrivere, specie in un’epoca in cui la narrativa italiana è carente di veri talenti. Tuttavia personalmente preferisco le parti in cui la scrittura si fa piana, si avvicina, specialmente nelle parti dialogiche, alle capacità espressive dei protagonisti.
Leggendo questo romanzo mi sono tornati alla mente I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Ciò che inferno non è, in fondo è simile al romanzo degli umili, racconta le vicende di oppressi e oppressori, di violenza e amore, di forza bruta e forza della Fede. Sullo sfondo la Storia, quella vera, in cui i personaggi si muovono nel pieno rispetto del criterio, caro a Manzoni, della verosimiglianza. Il grande romanziere partiva dalla convinzione che l’arte debba rappresentare il vero indagando la realtà e questo è, alla fine, ciò che muove anche D’Avenia, un Alessandro moderno che adegua la sua poetica ai tempi attuali, senza rinunciare alla lezione dei grandi Maestri.
[Per la biografia la fonte è Wikipedia; l’immagine di copertina è coperta da copyright © Marta D’Avenia]
VISITA ANCHE LA PAGINA “LE MIE LETTURE”
 Chiara Gamberale, classe 1977, è una scrittrice, giornalista, conduttrice radiofonica e televisiva italiana.
Chiara Gamberale, classe 1977, è una scrittrice, giornalista, conduttrice radiofonica e televisiva italiana.