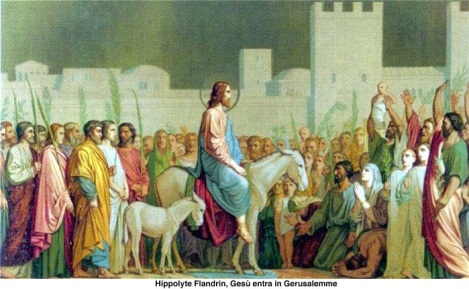PREMESSA
Ci sono libri che attendono di essere recensiti, da tanto, troppo tempo. Una vita. Selma Meerbaum-Eisinger (1924-1942) di Francesca Paolino è uno di questi. Mi scuso per il ritardo ma Francesca, con cui sono in contatto da un paio d’anni, forse più, sa che le circostanze sono state “avverse”. Questa biografia meritava momenti tranquilli, chiedeva di essere letta e riletta. Una lettura veloce non le avrebbe dato lo spazio e il tempo adeguato. Ora, a pochi giorni dalla visita che la dott.sa Paolino farà nel liceo in cui insegno, credo che il giusto tempo sia arrivato. Meglio tardi che mai, direbbe qualcuno. E avrebbe ragione.
L’AUTRICE
 Francesca Paolino (classe 1978) vive a Roma. Germanista e traduttrice, ha dedicato i suoi studi alla vita della giovane Selma Meerbaum-Eisiger, vittima della Shoah, pubblicandone prima la biografia (Una vita. Selma Meerbaum-Eisiger (1924-1942), Trento, Edizioni del Faro, 2013, e successivamente curando l’edizione delle sue poesie nella raccolta Florilegio (Trento, Edizioni Forme Libere, 2015). La studiosa e scrittrice affianca alle ricerche letterarie le attività di traduttrice e guida turistica.
Francesca Paolino (classe 1978) vive a Roma. Germanista e traduttrice, ha dedicato i suoi studi alla vita della giovane Selma Meerbaum-Eisiger, vittima della Shoah, pubblicandone prima la biografia (Una vita. Selma Meerbaum-Eisiger (1924-1942), Trento, Edizioni del Faro, 2013, e successivamente curando l’edizione delle sue poesie nella raccolta Florilegio (Trento, Edizioni Forme Libere, 2015). La studiosa e scrittrice affianca alle ricerche letterarie le attività di traduttrice e guida turistica.

IL LIBRO
Una vita. Selma Meerbaum-Eisinger (1924-1942) non è un romanzo, anche se sarebbe bello pensarlo come opera di fantasia perché ciò significherebbe che la ragazzina con il pallino della poesia avrebbe avuto una vita più lunga e, forse, un grande successo come scrittrice. Ma il destino ha troncato la sua giovane vita in un campo di lavoro in Ucraina, dove a soli 18 anni morì colpita inesorabilmente dal tifo.
Francesca Paolino nel suo libro ha ricostruito, con un’attenta analisi delle fonti, la biografia della giovane poetessa Selma Meerbaum-Eisinger, nata a Czernowitz, vecchia capitale della Bucovina (territorio attualmente diviso tra Romania e Ucraina, un tempo facente parte dell’Impero Austro-ungarico) il 5 febbraio 1924 e deportata nel campo di lavoro di Michajlovka, in Transnistria, in seguito alle persecuzioni naziste.
Nel libro della Poalino, la città di Czernowitz è descritta come un microcosmo nel microcosmo, la culla di un eccezionale multiculturalismo. Qui Selma cresce, dimostrando fin da giovanissima una vera e propria passione per la letteratura, favorita da un clima intellettuale vivace, in cui si parlavano almeno una dozzina di lingue, senza contare i dialetti e lo yiddish dei piccoli centri ebraici, anche se la cultura più fiorente era quella tedesca:
Il mito di Czernowitz è quello di un “paradiso perduto” nella regione più orientale dell’Impero, la fucina di una straordinaria vita intellettuale policroma, autonoma, feconda e originalissima (quella della Bucovina è definita la “quinta letteratura tedesca”), temprata dal sacro fuoco del deutscher Geist. (pag. 16 dell’edizione citata)
Come spiega l’autrice in una nota a pag. 18, quando la Bucovina viene annessa al Grande Regno di Romania (1918), nonostante l’affermarsi in un primo momento del bilinguismo tedesco-rumeno e il riconoscimento da parte del Regno di Romania di una certa autonomia agli ebrei bucovini, considerati “minoranza etnica e confessionale”, negli anni Trenta la rumenizzazione del territorio porta all’affermazione di un diffuso antisemitismo con il conseguente peggioramento delle condizioni economiche della famiglia di Selma che aveva già dovuto affrontare il dramma della morte precoce del padre Max, ucciso dalla tubercolosi a soli 29 anni.
La madre Frieda, imparentata con il poeta Paul Celan (il cui cognome di nascita era Antschel), si risposò con Leo Eisinger e non poté garantire alla figlia la stessa istruzione esclusiva impartita al cugino Paul. La giovane poetessa, infatti, “frequentò le scuole pubbliche sia nei quattro anni previsti per l’istruzione primaria … sia per i successivi otto anni di scuola secondaria frequentati all’Hoffmann-Lyzeum nella Altgasse e per l’anno scolastico 1940-41 (anno dell’occupazione sovietica di Czernowitz) alla Jüdische Schule in Austria-Platz. (pag. 28)
Grazie alle fotografie e alle testimonianze di alcuni amici, come Reneé e Margit Bartfeld, è stato possibile ricostruire alcuni tratti fisici e della personalità della ragazza. Alta un metro e sessanta, aveva i capelli castani e crespi che portava costretti in lunghe trecce, operazione complessa che la portava spesso a correre per arrivare in orario a scuola. Selma amava vestire in modo sportivo e pratico, indossando perfino i pantaloni corti, non era attratta dalle mondanità ma piuttosto era “affamata” di poesia, leggeva un libro dopo l’altro, sognava un futuro da scrittrice. (pag. 33)

Con l’ingresso nel gruppo sionistico dell’Haschomer Hatzair (“Giovane Sentinella”, nato a Vienna nel 1916 in seguito alla fusione di due precedenti movimenti giovanili), oltre a condividere con alcuni amici la passione per i versi, Selma si lascia trascinare anche dal ballo perché, come ricorda la compagna Else Keren, voleva vivere in pienezza ogni momento. Quasi un presentimento della morte precoce.
Gli Haschomer bucovini erano molto attivi culturalmente e appassionati di letteratura, filosofia e psicologia. Per la giovane poetessa quell’ambiente era l’ideale per coltivare il sogno nel cassetto. La città stessa offriva molti spunti per le sue poesie: Selma amava in particolare il Colle degli Asburgo, nella zona meridionale di Czernowitz, immortalato nei suoi componimenti, teatro di piccoli drammi entomologici o del tripudio di fioriture inaspettate e di luce vespertina (pag. 47), come si legge in una delle sue liriche che, assieme ad altre poesie, andrà a comporre la raccolta Blütenlese (Florilegio).
Selma e i suoi giovani amici trascorrevano le giornate in modo abbastanza spensierato, sperando in un futuro migliore. Pensavano che le difficoltà fossero passeggere e la minaccia nazista lontana: [Era] come un terribile incidente d’auto. Ha coinvolto altri, pensavamo, a noi non toccherà. (pag. 58)
Ma l’invasione della Polonia da parte delle truppe tedesche tolse la tranquillità alla comunità ebraica nella Bucovina. Infatti, anche in Romania, nell’autunno del 1939, i controlli sull’attività degli ebrei si fecero sempre più serrati. Il gruppo dell’Haschomer Hatzair, per evitare incidenti, limitò le proprie attività, soprattutto quelle all’aperto. Non al punto da impedire a Selma e alle altre “sentinelle” di festeggiare Chanukkah, la festa delle luci, una delle più importanti per le comunità ebraiche. L’amica Else Keren racconta che la notte della festa (dicembre 1939), durante una passeggiata al Colle degli Asburgo, Selma si fece silenziosa e si chiuse in se stessa. Poi la vidi scrivere nel suo libricino. Il quadernetto, spiega la Paolino, non fu mai ritrovato. Che cosa scrisse quella notte la giovane? Forse prese appunti per la composizione della poesia Farben (Colori):
È così azzurro sulla neve candida,
gli abeti verdi sono così neri,
che il capriolo, sgusciato di soppiatto,
è grigio come la pena senza fine,
che pure scacceresti volentieri.
Scricchiano passi, musica di neve,
e i venti rimandano polvere di fiocchi
sugli alberi velati di bianco.
Panchine come sogni.
Luci calanti vanno con le ombre
in girotondi infiniti.
Remote lanterne brillano d’un chiarore
attutito, preso allo sfavillìo della neve. (traduzione di Francesca Paolino, pag 60 di Una vita)
Sei mesi dopo, il 20 giugno 1940, l’Armata Rossa entrò a Czernowitz e i romeni furono costretti a cedere la città all’Unione Sovietica. Si diffuse un discreto ottimismo: Credevamo nel socialismo. L’entusiasmo per l’entrata delle truppe russe fu grande. (pag. 61)
Speranze andate presto deluse: in breve, proprio i russi iniziarono la deportazione degli ebrei. Inoltre, nella Bucovina la situazione era molto complessa a causa delle rivendicazioni del Reich per far rientrare in Germania i cittadini tedeschi. Naturalmente ariani. Molti riuscirono a scappare ma i russi, nella notte tra il 13 e il 14 giugno 1941, prelevarono con la forza 3800 cittadini di Czernowitz.
Quando, in seguito, la Romania entrò in guerra a fianco delle potenze dell’Asse, la situazione per gli ebrei si fece ancora più drammatica: il 7 luglio 1941 venne incendiata la sinagoga di Czernowitz e nello stesso anno, il 30 luglio, un’ordinanza firmata dal colonnello Alexandru Riosanu impose agli ebrei degli orari per uscire da casa, costringendoli a chiudere ogni attività professionale e ad appuntare sui vestiti la stella di David. Fu poi costruito il Ghetto, situato nel vecchio quartiere ebraico, circondato da una recinzione di assi e filo spinato ad altezza d’uomo. I due portoni d’accesso erano sorvegliati e gli abitanti dovevano attenersi a rigide regole per quanto riguardava il transito e la possibilità di portare viveri e beni di prima necessità. I più dedussero che la permanenza nel ghetto non sarebbe stata lunga. (pag. 70)
Selma non poteva più muoversi liberamente nella propria città. Molte amiche erano già state deportate dai russi e chi era ancora a Czernowitz, cercava come poteva una via di salvezza:
Quando la guerra arrivò dalle nostre parti, sentimmo di essere derubati della nostra giovinezza. Non ci era più permesso di recarci nei nostri giardini, sui nostri prati – dovevamo cercare nascondigli. In quelle sere lunghe e solitarie Selma scrisse le sue poesie più belle. (pag. 69)
In un primo tempo gli Eisinger riuscirono a rimanere nel ghetto, grazie anche alle “autorizzazioni” che il sindaco della città, Trajan Popovici, era riuscito a far ottenere per evitare la deportazione degli ebrei da parte delle autorità rumene. Ma la situazione precipita nel maggio del 1942, quando i rastrellamenti non lasciano scampo nemmeno alle persone protette dai certificati. Secondo alcune testimonianze, Selma partì per il campo di lavoro, assieme al patrigno Leo e alla madre Frieda, il 7 giugno.
Da questo momento la vita della giovane poetessa di Czernowitz è ricostruita, per sommi capi, in base ad alcune testimonianze, come quella dell’artista trentenne, originario di Suceava, Arnold Daghani il quale assieme alla moglie Anisoara era partito con lo stesso convoglio diretto in Transnistria su cui viaggiava anche la famiglia Eisinger. Nelle pagine del suo diario, che in realtà non avrebbe potuto tenere ma che abilmente aveva “mimetizzato” utilizzando un codice segreto per i suoi scritti, il 6 dicembre 1942 Daghani osserva:
[…] Povera Selma, da qualche tempo è malata. Una volta al ritorno dal cantiere l’ho sentita impegnarsi in una discussione sull’arte e sostenere che se un artista avesse l’intenzione di rappresentare in modo convincente la disumanità del campo, dovrebbe prendere spunto da un giudizio già formato. Ho percepito quest’affermazione come una critica al mio camaieu. Forse avrebbe preferito che avessi immortalato le esecuzioni? […] Perché impoverire l’orrore dipingendolo, disegnandolo? Forse i detenuti desiderano che il mondo sappia esattamente da un tratto di matita ciò che è avvenuto qui nel campo, perché chi potrebbe mai credere alle nostre parole, se dovessimo sopravvivere? (pagg. 86-87)

Nonostante dal tifo sia riuscito a guarire l’80-85% dei deportati al campo di Michajlovka, la malattia aggredì Selma senza lasciarle scampo. Il 16 dicembre morì e nel suo cappotto la madre trovò una lettera grazie alla quale apprese che, poco prima della scomparsa, la figlia aveva tentato di fuggire dal campo, con l’aiuto di una guardia. Una rivelazione che non deve stupirci: uno spirito libero come Selma non avrebbe mai voluto finire i suoi giorni in un campo di lavoro che l’aveva privata della sua libertà, senza poter godere della bellezza dei luoghi a lei cari, rinunciando ad inebriarsi dei profumi della natura e a lasciarsi accarezzare dal vento.
Il vento canta la sua ninna nanna
con un fruscìo di sogno,
teneramente adula le foglie.
Mi lascio sedurre e spio quel canto
e mi sento come i prati.
Scrosci nell’aria
rinfrescano il mio viso
cocente, racchiuso nell’attesa.
Nuvole in viaggio riversano la bianca
luce che hanno rubato al sole.
La vecchia acacia
spande il suo silenzio
nel tremulo intrico di foglie.
Gli aromi della terra si alzano, salgono
e scendono poi su di me. (Mattino, da Florilegio, pag. 183, traduzione di Francesca Paolino)
Questa ed altre poesie sono l’eredità che ci è rimasta di Selma Meerbaum-Eisinger. In un quadernetto costituito da una copertina rigida e dei fogli tenuti assieme da un cordoncino, impreziosito da un foglio di carta da regalo con motivo floreale su sfondo azzurro, incollato sul cartoncino che ne costituisce la copertina, la giovane poetessa aveva scritto a mano le sue poesie. Blütenlese (Florilegio) è il titolo della raccolta che testimonia la gioia di vivere, la passione per i versi e, in ultimo, la parte dolorosa della breve esistenza di Selma.
Ricorda l’amica Else Keren: Ella cercava il bello e aveva il dono di trovare qualcosa di bello in tutto. E poi: Se Selma fosse vissuta … quante cose ancora avrebbe potuto darci?
Con la matita rossa, a conclusione della raccolta delle sue poesie dedicate all’amico Leiser Fichman, il ragazzo di cui era innamorata ma non seriamente ricambiata, Selma scrisse:
Non ho avuto il tempo di finire di scrivere.
Chissà quanto altro avrebbe potuto dirci.
***
Quello che colpisce, in particolare, nella lettura di Una vita e Florilegio è la storia di questa ragazza e il suo triste destino, condiviso da milioni di ebrei. Siamo perlopiù abituati a leggere libri di testimonianze che hanno rivelato al mondo l’orrore dei campi di concentramento, della morte nelle camere a gas, della privazione di ogni parvenza di dignità umana. Oppure leggiamo romanzi ispirati a queste storie che, pur essendo opere di fantasia, contribuiscono a lasciare memoria dell’Olocausto.
La particolarità degli scritti della Paolino è, invece, quella di far rinascere, perpetuandone la memoria, non solo una testimonianza ma la vita stessa di questa giovane poetessa che ha lasciato ai posteri oltre al ricordo delle sue sofferenze, che mai sovrastano la bellezza della natura descritta con passione e partecipazione, la prova di un grande talento poetico unito a un amore incondizionato per la vita.
In Una vita si notano soprattutto la cura e la precisione nella ricostruzione biografica attenta ed esaustiva, l’analisi meticolosa delle fonti con cui Paolino ricostruisce anche il contesto storico. In Florilegio l’autrice dà mostra della sua abilità nella traduzione che non è solo “transcodificazione” – passaggio da una lingua all’altra – ma anche resa emozionante dei sentimenti che animavano Selma durante la stesura.
Infine, sia nella biografia sia nella raccolta di poesie, relativamente all’introduzione, la scrittrice utilizza uno stile armonioso che riesce a compensare l’asciuttezza tipica del saggio e rende assai gradevole la lettura. Da entrambi i libri, inoltre, traspare un amore per Selma e l’orgoglio di aver contribuito a diffondere in Italia questa bella storia, seppur amara nella sua conclusione, e un album di poesie «lanciato con forza inaudita attraverso gli anni a venire così da rompere la cortina dell’oblio, attraversando i silenzi del dopoguerra, i pregiudizi sulla lingua tedesca e sulla giovane età che lo creò» (Florilegio, pag. 9).
[immagini tratte dal libro di F. Paolino e dal web. Nel caso in cui alcune di esse siano coperte da copyright, prego i soggetti interessati di contattarmi per e-mail]
CONTINUA>>>