
Così inizia il carme 13 di Catullo, famoso poeta latino vissuto nel I secolo a.C. Ecco il testo originale:
Cenabis bene, mi Fabulle, apud me
paucis, si tibi di favent, diebus,
si tecum attuleris bonam atque magnam
cenam, non sine candida puella
et vino et sale et omnibus cachinnis.
Haec si, inquam, attuleris, venuste noster,
cenabis bene; nam tui Catulli
plenus sacculus est aranearum.
Sed contra accipies meros amores,
seu quid suavius elegantiusve est:
nam unguentum dabo, quod meae puellae
donarunt Veneres Cupidinesque;
quod tu cum olfacies, deos rogabis
totum ut te faciant, Fabulle, nasum.
Famoso lo era davvero, Catullo, ma non tanto per l’attività poetica, quanto per l’amore appassionato che gli ispirò gli indimenticabili versi dedicati a Lesbia. Ma di questo ho già parlato in un altro post. (LINK )
L’attività poetica, a quanto pare, non doveva essere molto redditizia; infatti, al verso 8 del carme confessa all’amico Fabullo, che si era autoinvitato a cena, di essere senza il becco di un quattrino, come diremmo noi adesso. All’ospite, quindi, non restava altro da fare che portarsi dietro il cibo, e non solo: avrebbe dovuto provvedere anche all’escort di turno, una “candida fanciulla”, magari procurarsi anche del vino e un po’ di allegria. Pare, infatti, che gli antichi Romani apprezzassero molto l’allegria e il divertimento, oltre che il buon cibo.
In cambio di tutto questo ben di dio, però, Catullo era in grado di offrire all’amico un unguento meraviglioso che gli stessi dei dell’amore avevano procurato alla sua fanciulla, un unguento talmente odoroso che alla fine Fabullo avrebbe pregato gli dei di trasformarlo in un … naso. Era usanza, infatti, che ai convitati si offrissero dei profumi preziosi, in forma d’unguento, che di solito erano contenuti in pregiate boccette e, a seconda delle essenze profumate utilizzate, potevano essere davvero molto costosi.
Ma cosa mangiavano in realtà gli antichi Romani?
Considerando che agli inizi della loro storia erano un popolo dedito prettamente all’agricoltura e all’allevamento, possiamo supporre che si nutrissero dei prodotti ricavati da tali attività. Prodotti tipici erano, ad esempio, l’olio, il vino, i farinacei, i legumi, le verdure coltivate negli horti e le erbe selvatiche della cui raccolta si occupavano prevalentemente le donne. Gli animali da cortile producevano le uova ma non venivano quasi mai mangiati; le galline, infatti, erano più sacre delle vacche in India. Qualche galletto ogni tanto finiva sulla brace, ma nulla di più. Si allevavano prevalentemente ovini e suini, ma la carne preferita era quella che proveniva dalla caccia della selvaggina, soprattutto cinghiali. La carne bovina, invece, non veniva consumata perché i buoi erano animali da lavoro: macellare un bue era come uccidere uno schiavo ed era anche un reato punito con la confisca dei beni del reo e il suo esilio, quando addirittura non veniva condannato a morte. Questo almeno fino alla fine del II secolo a.C. Poi, anche in cucina, arrivarono le mode estere, quindi i gusti dei Romani cambiarono. La carne dei grossi animali, però, rimaneva un cibo di lusso perché la loro macellazione era laboriosa e la preparazione per la cottura richiedeva l’uso di spezie anche molto costose.
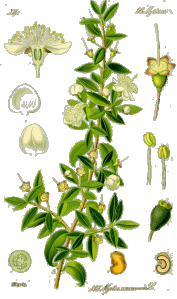 Quando la cucina romana era ancora frugale, per insaporire il cibo – sarebbe meglio dire per coprire il gusto terribile della carne marcescente, dato che la conservazione era difficile in assenza di frigoriferi e congelatori – si usavano le bacche di mirto; poi dall’oriente si iniziò ad importare il pepe che dovette piacere moltissimo ai Romani visto che lo mettevano anche nei dolci. La tradizione è giunta fino a noi: uno dei dolci tipici della cucina laziale è appunto il “pan pepato”. Il mirto continuò ad essere usato negli insaccati, in particolare nella mortadella che ancor oggi conserva nel suo nome il ricordo della spezia usata anticamente (da murta= mirto).
Quando la cucina romana era ancora frugale, per insaporire il cibo – sarebbe meglio dire per coprire il gusto terribile della carne marcescente, dato che la conservazione era difficile in assenza di frigoriferi e congelatori – si usavano le bacche di mirto; poi dall’oriente si iniziò ad importare il pepe che dovette piacere moltissimo ai Romani visto che lo mettevano anche nei dolci. La tradizione è giunta fino a noi: uno dei dolci tipici della cucina laziale è appunto il “pan pepato”. Il mirto continuò ad essere usato negli insaccati, in particolare nella mortadella che ancor oggi conserva nel suo nome il ricordo della spezia usata anticamente (da murta= mirto).
La dieta vegetariana poteva contare su una gran quantità di verdure che venivano consumate preferibilmente crude, inzuppate in un po’ d’aceto: l’antenato del nostro pinzimonio, insomma. Quelle cotte erano una pietanza da ricchi: secondo Catone il Censore, autore di un trattato intitolato De Agricultura, bisognava farne a meno perché, dovendosi utilizzare l’olio come condimento, era uno spreco tanto d’olio quanto di denaro. Ma lui, come si sa, era un po’ tirchio e soprattutto non amava il lusso. Infatti, s’incavolava parecchio perché le conquiste in Oriente avevano portato a Roma quella che lui definiva la luxuria asiatica, trasformando un popolo semplice e molto virtuoso, anche se un tantino rozzo, in un ammasso di pappemolli dedite a banchetti spropositati. Catone lamentava lo spreco di denaro che talvolta si faceva anche per dimostrare di poter offrire banchetti luculliani agli ospiti: si arrivava a spendere per un pesce più di quanto si pagasse un bue per lavorare i campi, il che, per uno come lui, era davvero una cosa impensabile. Forse non scherzava affatto, visto che, a proposito del costo del pesce, un po’ di tempo dopo (siamo nel I secolo d.C.) Giovenale ci racconta che un certo Crispino, cortigiano di Domiziano, aveva speso per una triglia, del peso di due chili (ma lo stesso Giovenale ipotizza che il peso fosse gonfiato dalla fantasia popolare!), ben 6000 sesterzi, circa 4000 euro. Ovviamente tutto ciò valeva per i ricchi perché i poveri in tutte le epoche non se la sono mai passata bene, indipendentemente dalle conquiste militari.
Con l’andar del tempo gli sprechi aumentarono, anche perché nel frattempo Catone il Brontolone era passato a miglior vita. I dati relativi al commercio con l’Oriente sono indicativi: nel I secolo d.C. si registravano scambi con l’India per ben 100.000.000 di sesterzi, l’equivalente più o meno di 70 milioni di euro odierni. E se Catone non poteva più tuonare contro gli sprechi, suo degno successore fu Plinio il Vecchio che, tuttavia, gridava al vento. I Romani, ormai, si crogiolavano nel lusso e non badavano affatto alle proteste e ai moniti dei vecchi brontoloni. 
Offrire un banchetto, proprio perché era un chiaro segnale di prestigio sociale, poteva costare un occhio della testa. Fra i tanti nababbi la palma del più spendaccione spetta sicuramente a Lucullo (tant’è che ancor oggi si usa l’aggettivo “luculliano” per riferirsi ad un pasto particolarmente abbondante e ricco). Da Plutarco sappiamo che una cenetta offerta nella “sala di Apollo”, il triclinio preferito, a due ospiti d’eccezione, Pompeo e Cicerone, gli costò ben 50.000 sesterzi, vale a dire circa 33.000 euro. C’è da dire, però, che il cibo avanzato non veniva quasi mai buttato: era usanza portar da casa una grande salvietta, detta mappa, che serviva ai commensali per avvolgere gli avanzi e portarseli a casa. Una sorta di doggy bag ante litteram, insomma.
Per poter imbandire banchetti succulenti c’era bisogno di esperti nell’arte culinaria. Uno di questi, Apicio, non sarebbe probabilmente passato alla storia, se il suo ricettario, il De re coquinaria, non fosse giunto fino a noi. Fu talmente famoso ai suoi tempi che da allora tutti i cuochi vennero chiamati Apicio. Ma se sfogliamo le pagine del suo libro, rimaniamo delusi: prima di tutto nelle ricette non sono quasi mai riportate le dosi. Ciò può essere spiegato con la bravura che ancor oggi viene attribuita agli chef di cucinare “a occhio”. Gli elenchi di ingredienti che si trovano nel De re coquinaria sono in realtà dei promemoria e le uniche dosi presenti riguardano le ricette dietetiche che rientravano nelle prescrizioni mediche.
Da Apicio sappiamo che gli abitanti dell’impero non usavano quasi mai il sale come condimento, un po’ per il suo costo (proprio per questo preferivano utilizzarlo per la conservazione dei cibi) e un po’ perché con l’umidità tendeva a diventare una specie di pappetta difficile da dosare. Al suo posto veniva utilizzato il garum, una sorta di pasta d’acciughe moderna. Non siamo sicuri che fosse una prelibatezza, anche se il suo costo poteva esser molto alto; Plinio il Vecchio non lo sopportava e lo definiva “marciume di pesce”. Ma non tutto il garum gli faceva così schifo: quello che arrivava dall’Africa e dal sud-ovest della Spagna aveva il colore del miele ed era talmente buono che lo si poteva bere a bicchierini. Mah, i Romani dovevano essere ben strani!
Apicio parla anche di un altro condimento, più semplice, chiamato liquamen –il nome non è per nulla rassicurante- che probabilmente indicava solo una soluzione di acqua e sale, più o meno la nostra salamoia.
Poi c’era il silfio, una pianta selvatica che cresceva nei pressi di Cirene: il suo succo, chiamato laser, una volta estratto, a contatto con l’aria si solidificava ed era venduto a peso d’oro anche perché la pianta non poteva essere coltivata. Insomma, tra il garum, il,siflio, le spezie indiane, gli animali e i cibi esotici un pasto poteva diventare davvero costoso. C’era anche chi, per dimostrare il prestigio e l’autorità, si cimentava in delle vere e proprie gare culinarie.

Si narra che la regina Cleopatra avesse scommesso con Marco Antonio di essere capace di spendere una vera e propria follia: più di 10 milioni di sesterzi, circa 7 milioni e mezzo di euro. Il banchetto offerto fu davvero strepitoso ma Antonio era convinto di poter far di meglio. Tuttavia non aveva fatto i conti con la stravaganza di Cleopatra: la regina si fece portare una coppa d’aceto, si tolse una delle magnifiche perle che aveva indosso, un gioiello di valore inestimabile, la sciolse nel liquido e la bevve. Quando fu sul punto di sfilarsi l’altro orecchino fu bloccata dall’amante che riconobbe la sconfitta e pagò il conto.
Vediamo ora in che cosa consisteva una cena romana, iniziando dall’antipasto.
C’è un detto popolare, ab ovo, che ci fa ben capire che i Romani iniziavano il pasto proprio da lì: dalle uova. Per essere precisi, si diceva ab ovo usque ad mala per indicare i due estremi del pasto: vale a dire, dalle uova alla frutta.
Oltre alle uova, per antipasto venivano consumate anche le olive, i ceci bolliti e delle foglie d’insalata, esattamente quella varietà che oggi chiamiamo “lattuga romana”, che venivano mordicchiate dopo essere state inzuppate nell’aceto, come si è detto in precedenza. Costituiva un’ottima alternativa il tonno che veniva accompagnato dall’erba cipollina o porri. Ma anche in questo caso, le uova non mancavano mai.
Il tutto era accompagnato da una specie di focaccine: si tratta del libum (etimologicamente legato al verbo “libare”), la cui ricetta ci è stata tramandata dal Censore, a base di farina, uova e formaggi freschi della zona.
Il formaggio, inizialmente ricavato dal latte di capra e di pecora, costituiva la seconda portata della cena romana. Solo verso il I secolo a.C. si iniziò a produrre anche il formaggio dal latte vaccino.
Svetonio nella sua opera Vite dei dodici Cesari tramanda che l’imperatore Augusto era particolarmente ghiotto di caseum bubulum che di certo non poteva essere annoverato fra i prodotti di lusso degni di un imperatore. Egli, tuttavia, accontentandosi di pasti frugali visse ben 77 anni!
I Romani amavano lavorare il formaggio mischiandovi erbe, noci, pinoli o sesamo, un po’ come succede ora con i fromage aux fines herbes ed altre specialità francesi che, però, sono tutt’altro che a buon mercato.
I primi piatti non erano molto di moda perché i Romani preferivano passare direttamente al piatto forte costituito dalle carni. Le minestre, poi, erano difficili da mangiare sdraiati sul triclinio e per questo costituivano piuttosto la cena dei poveri che non potevano permettersi di consumare le pietanze a base di carne. Non mancano, tuttavia, nel libro di Apicio delle ricette di primi piatti, c’è persino quella della lasagna chiamata Piatina cotidiana. A leggerla, però, non si direbbe un piatto particolarmente invitante per il nostro palato. Il termine “pasticcio” risulta essere più che appropriato: la “piatina”, infatti, è un misto di “poppa di scrofa”, pesce e carne di pollo, il tutto annaffiato con il liquamen, un po’ di vino e degli aromi e uova sbattute a costituire il sugo che veniva alternato, nella padella, al laganum, ovvero la sfoglia di pasta. Ed ecco spiegato il nome della nostra mitica lasagna, anche se attualmente l’emiliana è più nota della laziale. Quanto al gusto, non ci giurerei che fosse proprio strepitoso.
Oltre alle minestre e alla zuppa di pesce, nell’antica Roma si usava cibarsi anche della polenta. Ma come, direte voi, se il mais ancora non lo conoscevano? Be’, in effetti, loro usavano il farro e l’alica, una specie di semolone di grano duro. Sempre il nostro Apicio ci riporta una ricetta per fare la polenta accompagnata dalla salsa oenococta, ovvero di vino, nella quale si cuocevano talvolta le braciole di maiale.

Nei banchetti della Roma bene il piatto forte era costituito, come già detto, dalla carne. Ma i peccati di gola spesso si scontavano con l’arrivo dell’odiata gotta: ne soffrivano in molti, appartenenti alle classi più abbienti e anche in giovane età. Non ne fu immune nemmeno Marco Antonio che morì a 53 anni, non troppo vecchio per quei tempi ma nemmeno così giovane.
La carne maggiormente servita nei banchetti dei ricchi era quella suina e ovina, in particolare il capretto. Apicio nel suo De re coquinaria trascrive anche la ricetta del “prosciutto in crosta”: Preso un prosciutto e lessato con moltissimi fichi secchi e tre foglie di alloro, lo si scuoia, si incide a rombi e lo si inzuppa di miele. Poi si fa una pasta con farina e olio e se ne riveste il prosciutto. Quando la pasta sarà cotta, la si leva dal forno. Pare che questa ricetta si esegua ancor oggi in America dove, al posto dei fichi secchi, si usa la melassa.
Accanto alle braciole di maiale, al capretto al forno e al prosciutto, i Romani usavano servire le interiora, tuttora molto utilizzate nella cucina laziale. Fegatelli, cervella, rognoni e fegato erano e continuano ad essere delle vere prelibatezze, servite ancor oggi nelle trattorie dei Castelli Romani.
Come ho già detto, il consumo della carne bovina era proibito fino al II secolo a.C., quindi era impensabile preparare, ad esempio, una buona trippa. Si tramanda che un riccone, tanto goloso quanto incauto, fece uccidere un bue per preparare una gustosa e invitante trippa da offrire al giovane amante; qualcuno evidentemente spifferò in giro l’atto sacrilego e il poveretto fu condannato alla confisca dei beni e all’esilio. Tutto per una trippa!
Oltre a quella di maiale, la carne certamente più diffusa era quella degli animali da cortile, nonostante il loro consumo fosse anch’esso limitato fino al II secolo a.C. Le galline, ad esempio, venivano allevate specie per le uova, come raccomanda nel De agricoltura Catone ad una fattoressa. Solo quando erano vecchie si potevano ammazzare ma la carne era così dura da mangiare arrosto che si preferiva farne un brodo. Da qui il detto “gallina vecchia fa buon brodo”.
Altri volatili particolarmente apprezzati erano le oche dal cui fegato si ricavava il foi gras. Secondo Plinio il merito della diffusione di questa leccornia, ancora tanto in voga da aver travalicato i confini della Francia, si deve al console Metello Scipione che, però, dovette in effetti solo trasmettere ai Romani un’usanza già diffusa dai Greci nel IV secolo a.C.
Anche i pavoni pare venissero mangiati ma erano costosissimi. Marziale, in uno dei suoi epigrammi, ironizza sulla loro diffusione tra i ceti abbienti facendo dire al contadino Ofello che un pavone non valeva un buon pollo. L’unica differenza tra i due erano le piume ma Ofello saggiamente osserva: “Non te le mangi mica le piume!”.
 Come ho già detto all’inizio, i Romani amavano moltissimo il pesce ed erano disposti a spendere delle follie per ostentare la ricchezza dei loro banchetti. Non solo, pare fossero dei veri e propri esperti della fauna ittica. Si racconta che un certo Montano, contemporaneo di Nerone, si vantasse di saper distinguere al primo assaggio un’ostrica proveniente da lago di Lucerino da quella pescata nel largo del Circeo e che Apicio avesse affrontato un periglioso viaggio fino alle coste libiche per pescare dei crostacei, ma che giunto fin là, avesse deciso di tornare indietro, a ceste vuote, perché non vi aveva trovato alcuna differenza con quelli laziali.
Come ho già detto all’inizio, i Romani amavano moltissimo il pesce ed erano disposti a spendere delle follie per ostentare la ricchezza dei loro banchetti. Non solo, pare fossero dei veri e propri esperti della fauna ittica. Si racconta che un certo Montano, contemporaneo di Nerone, si vantasse di saper distinguere al primo assaggio un’ostrica proveniente da lago di Lucerino da quella pescata nel largo del Circeo e che Apicio avesse affrontato un periglioso viaggio fino alle coste libiche per pescare dei crostacei, ma che giunto fin là, avesse deciso di tornare indietro, a ceste vuote, perché non vi aveva trovato alcuna differenza con quelli laziali.
A parte i crostacei, triglie, murene e spigole erano particolarmente apprezzate, cotte in vario modo, anche sotto forma di tortini. Molto utilizzato per insaporire il pesce era l’aceto, al posto del limone che noi preferiamo. Pare che i Romani mettessero questo agrume nei cassetti per allontanare le tarme o che lo mangiassero attribuendogli il potere di antidoto contro i morsi dei serpenti. Di utilizzarlo in cucina, però, non ci pensavano nemmeno.
Anche sul consumo delle verdure si è già parlato. Non mancavano mai sulle tavole dei Romani, poveri o ricchi che fossero. Particolarmente apprezzato era il cavolo. Catone lo considerava un toccasana anche contro gli effetti molesti delle sbornie: ne mangiava in gran quantità, inzuppando le foglie nell’aceto, prima di andare a cena e quando rientrava dal banchetto. Si vantava di avere sempre evitato di ubriacarsi facendo ricorso a questo semplice accorgimento.
Pare che i cavoli non mancassero nemmeno sulle tavole imperiali: Tiberio si sarebbe arrabbiato più volte con il figlio Druso perché si rifiutava di mangiarlo, anche perché Apicio l’aveva convinto che facesse schifo. Come si può ben osservare, ai bambini non piacciono le verdure, tantomeno i cavoli … nemmeno a quelli dell’antica Roma.
Onnipresenti sulle antiche tavole erano anche i legumi, come fave, ceci e lenticchie; non mancavano i tartufi, sia quelli di Norcia sia quelli libici, le tertezie, che hanno tutt’altro gusto e profumo da non reggere minimamente il confronto con i locali. Apicio, tuttavia, disprezzava le verdure e le sue ricette a base di vegetali non sono particolarmente invitanti.
Dulcis in fundo … il dessert non pare fosse servito alla fine della cena. Se riprendiamo in esame il detto ab ovo usque ad mala, dobbiamo concludere che il pasto degli antichi Romani vedeva nella frutta, specie nelle mele, l’usuale epilogo. Probabilmente i dolci venivano consumati fuori pasto, anche se c’è una testimonianza di Petronio che nel Satyricon, in occasione della famosa cena di Trimalcione, descrive una monumentale portata costituita da un trionfo di pasta sfoglia dolce foggiata a forma di Priapo (divinità rappresentata con un enorme fallo) che reggeva nel suo grembo un’immensa quantità di frutta ed era circondato da torte.
Un dolce molto comune aveva un nome che poi è stato utilizzato per definire tutt’altra cosa: la placenta. Il termine deriva dal greco plakois e significa semplicemente focaccia; si suppone che la parola sia stata poi usata per definire la “sacca” entro la quale cresce il feto nel grembo materno proprio per la particolare forma. Insomma, la placenta è il “dolce della mamma”.
I Romani ne confezionavano di gigantesche: ad esempio, quella di cui ci fornisce la ricetta Catone nel suo De agricoltura pesa addirittura più di otto chili. Ha un solo difetto: visto che si utilizzava il miele come dolcificante ed era caro, Catone, con l’occhio alla spesa che non doveva essere mai esagerata, ne usava pochissimo, quindi il sapore non doveva essere un granché. 
Accanto alla placenta si preparavano i globi, delle focaccine tonde a base di formaggio fresco e alica che si ricavava da un tipo di grano duro proveniente dalla montagna, detto anche triticum dicoccum per la difficoltà con cui si riusciva a decorticarlo. I globi venivano generalmente fritti, bagnati con il miele e spolverati con i semi di papavero.
Ma il capolavoro dei capolavori è costituito dalla cosiddetta cassata di Oplontis. Di questo dolce non esiste una ricetta ma è stato “ricostruito” sulla base di un affresco che si trova in uno dei triclini (sale da pranzo) della villa di Oplontis (Torre Annunziata), basandosi anche sul tradizionale dolce siciliano, con cui ha in comune gran parte degli ingredienti. (per la ricetta clicca QUI)
E dopo aver curiosato nei triclini degli antichi Romani, non resta che augurare a tutti BUON APPETITO! Meglio, però, gustare le nostre saporite ricette moderne, piuttosto che quelle un po’ sciape e alquanto improbabili dei nostri progenitori.
[nelle immagini: alcuni dipinti di Sir Lawrence Alma Tadema; foto dei resti della villa di Lucullo presso Pizzofalcone; la foto del particolare dell’affresco del pesce è di Giovanni Lattanzi]

L’ha ribloggato su Marisa Moles's Webloge ha commentato:
Come mangiavano gli antichi Romani? Le fonti ci danno molte informazioni ma, onestamente, non sembrano prelibatezze culinarie paragonabili a quelle moderne. In fondo, come si usa dire proprio riprendendo un detto latino, de gustibus non est disputandum.
Buona lettura … magari provate qualche ricetta.
"Mi piace""Mi piace"
Carissima Marisa lo sai che con mio marito partecipammo sull’Appia antica in una villa privata ad un pranzo tutto a base di cibi dell’antica Roma? Con una ghirlanda in testa assaggiammo varie cosette dai gusti anche forti. Ricordo un involtino chiuso da una foglia d’alloro. Chissà cos’era…Fu comunque molto divertente, sotto un pergolato, in un bel giardino. Ti abbraccio. Isabella
"Mi piace""Mi piace"
@ tachimio
Un’esperienza nuova, se non altro. Le antiche ricette poi sono senz’altro rivedute e corrette quindi non credo che il cibo fosse cattivo. Qui ci sono spesso rievocazioni medioevali e, pur avendo partecipato a diversi eventi, non ho mai avuto il coraggio di assaggiare nulla, anche perchè quasi tutto era a base di carne di montone e a me la carne non piace, figuriamoci il montone.
Ciao, Isabella. Un abbraccio.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Mi fai sempre sorridere cara Marisa. Un abbraccio. Isabella
"Mi piace""Mi piace"